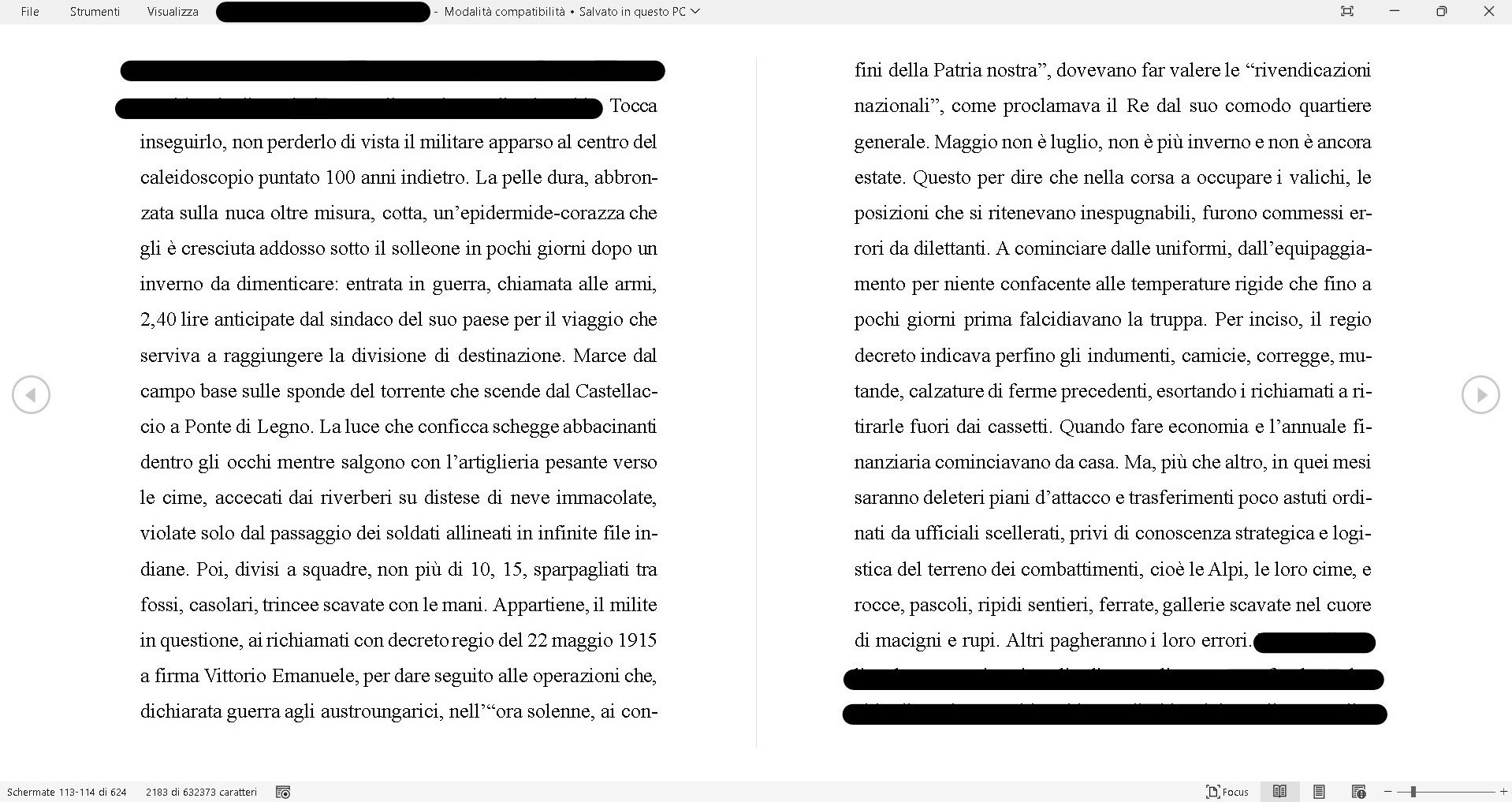(pubblicato su L’Almanacco 2005 – Il teatro del racconto, ed. Portofranco, aprile 2005)
:::
Teatro e narrazione
E’ possibile che, come sempre, alla fine si tratti soltanto di trovare un’intesa – provvisoria, quanto meno – sul linguaggio che usiamo. Le categorie, le definizioni – tutte le categorie e tutte le definizioni -, in quanto tali, sono tentazioni. Hanno una doppia vita, ed esistono per essere smentite, o tutt’al più, permanentemente verificate. L’equivoco, anzi, tutto l’apparato (festoso, gaio, becero, a volte fruttuoso) di fraintendimenti si insinua là dove si cede appunto alla tentazione di darle per scontate.
L’osservazione critica – intesa come militanza analitica classificatoria, di tipo accademico o semplicemente come pulsione, sguardo che legge e che interpreta sistematizzando il proprio sapere – conia con una certa frequenza etichette e categorie di cui, evidentemente, ci si serve per istituire discorsi (di ricerca, conoscenza, ma anche di strategico dispiegamento del proprio potere o della propria posizione) il cui dato incontrovertibile è di cercare (e poggiare su) un piano di realtà di derivazione scientifica, oggettivabile, quindi non solo visibile ma misurabile, quantificabile.
Non si può certo rimproverare a questo sguardo critico il proprio limite ovvero la propria virtù, che è appunto di ri-nominare gli oggetti di cui si occupa traendone regole e classificazioni generali, utili a una lettura appunto dei singoli fenomeni o della realtà.
Quello su cui è possibile eccepire è la sottile arroganza implicita in questa nominazione allorché la descrizione categorica (dogmatica) dell’oggetto preso in esame usa gli statuti immanenti e necessari della misurazione, della statistica, della visibilità, della manipolabilità dei propri oggetti per legittimarsi e sclerotizzare l’enciclopedia delle classificazioni, bypassando le dinamiche non prevedibili dei significati e dei sensi, dando appunto per scontato la bontà dimostrabile (con i dati) delle proprie categorie e dei discorsi su di esse.
Il teatro di narrazione o il teatro-racconto, per venire al tema specifico sollecitato in questa occasione, sono esempi perfetti e alquanto bizzarri delle categorie prodotte da quello sguardo. Intanto perché nel tentativo di analizzare, descrivere, fotografare un fenomeno in cui sembrano manifestarsi ripetute ricorrenze (l’accento narrante o il racconto che entrano in misura considerevole nello “specifico” teatrale) producono per l’appunto una tentazione, un’intossicazione linguistica che, proponendosi di nominare un oggetto per renderlo riconoscibile (o per cultualizzarlo, sponsorizzandolo, fregiandosi d’averne inventato la classificazione, un po’ come avviene da molti decenni con la critica d’arte) si serve con disprezzo (o ignoranza) dei significati aurorali convocati dall’etichetta (in questo caso formata dall’allegra connessione fra teatro e, appunto, racconto), significati (o concetti, oggetti, nature, esperienze) che quasi sempre pre-esistono.
Che il gioco sia fragile e la mistificazione facilmente smontabile è evidente. A meno di non rassegnarci all’apoteosi del tautologico, dovremo riconoscere che teatro di narrazione è sintagma di scarso significato. Soprattutto se si riflette su una condizione ontologica che riguarda, per cominciare, la relazione tra storia, racconto, appunto, e esistenza individuale.
Non potendo, fin dal momento in cui si comincia a lallare (e su su fino al primo germe di consapevolezza dato dal linguaggio, unico, residuo oggi giorno, spazio di effettiva incarnazione) nemmeno concepirci se non in una storia, ovvero in un racconto, un’asserzione, un grumo più o meno coordinato di significati e correlazioni, appare quanto meno ozioso discettare sulla relazione fra il teatro e il raccontare.
Il dio-bambino, che all’inizio concepisce il mondo esclusivamente come propia emanazione, si comincia a separare, cioè incomincia finalmente a riconoscere il suo sé accanto a altro da sé, comincia a identificarsi identificando l’altro, proprio con l’uso del linguaggio e della nominazione. Esperienza che, peraltro, gli consente di strutturare una prima ipotesi di senso della propria esperienza e di quella, più ampia, del mondo, all’intero di una storia.
Come si vede, quel che ingenera soverchia confusione, come spesso accade, è il significare, quello che si vuole dire, che è dettato, anche, dal suo come. Ma quando scende nell’agone, quel tipo di osservazione critica – intesa come pretesa classificatoria esaustiva – assume carattere e fattezze da buontempone, compiacendosi, per esempio di conficcare nell’oggetto del contendere il teatrare e il raccontare intesi, ognuno, come prontuario, genere, peculiarità espressive già codificate come prescrizione nell’enciclopediario del rappresentare, crocevia di repertori e tradizioni, è vero, ma anche di regole e di veti sottoposti a vigilanze un po’ forzate, da condominiale amministrazione.
In questa disposizione, com’è noto, sboccia un chiacchiericcio, ingrassato di glabri e sterili citazionismi, in cui ciascuno, con diversi scopi, si sbraccia a perditempo, considerando quanto dell’un genere influenzi o entri o penetri o asseocondi o copuli con l’altro; nell’inutile quanto dannosa compilazione di statistiche sclerotiche sul nascere e pronte a essere sostituite dalle idee brillanti prossime venture.
Sono proprio queste idee brillanti, spesso vanigliose o maionesizzate, ad avere forma tipica di insidia, moda; nascono cioè più spesso per dar titoli, di tempo in tempo, a ciò che, senza il packaging di slogan, schemi, non avrebbe posto, per esempio, dentro i media (si parlerà, un giorno o l’altro dell’imbarazzante, e a volte anche colpevole, accondiscendenza con cui scambiamo la realtà con quella rappresentata dai media); vengon messe in piedi con le grucce per crear fenomeni, pettegolezzi, tutti accademicamente istituzionalizzati sotto titoletti per palati buoni.
Buone spesso, queste operazioni, per gli intenditori, cosiddetti tali, inclini a legittimarsi con gli insiemi trendy, ispirati a spunti fenomenici tutt’altro che omogeneizzati, ma da loro stessi impacchettati, al di là dei sensi e dei significati, per creare insiemi la cui forza sta nella statistica, nei numeri, tanto cari a stampe e televisioni, usi a dare rilevanza ai propri oggetti con il metro dell’aritmetica.
C’è qualcuno, dunque, che ricava i propri orgasmi dai sondaggi; strano metodo per irretire l’audience o l’interlocutore, con classifiche in cui si stabilisce ciò che vale; e il principio più sovrano, ambiguo e inflazionato, per lo più sfruttato con metodo corsaro, è di stabilire, grazie appunto a conteggi e formule, quel che è “nuovo”.
Ma a quel “nuovo”, la parola, intendo, l’aggettivo, si ricorre sempre e solo quando un qualche d’uno ha da vendere qualcosa a un altro; dunque, il gioco è smascherato; e stiano pure in pace i convintissimi propognatori promotori di cataloghi, gli agenti e i rappresentanti di quei “nuovi”; anche se, come si evince, il gioco non esclude conseguenze criminali, nessuno impedirà loro di continuare coi giochini.
Anche perché, tornando al dunque, cioè al teatro e alla sua relazione col racconto, e provando a parlar chiaro: tra il sopravvivere e il potere circuitare, in tempi di legiferazioni dirigiste e dogmatismi imperituri, appare comodo metter su un bel raccontino, un solo attore e farlo girare; non si vive d’aria, insomma; salvo poi chiamarlo con nomignoli sofisticati e magari aver pretese di persino primogeniture o depositar brevetti, anche; leggi: bada al budget.
Così accade che quello che doveva essere strumento per analizzare e nominare un fenomeno apparente (l’uso più frequente e frequentabile del raccontare, con accenti che squadernano le convenzioni a cui siamo abituai) si risolve in comodo contenitore in cui far passare quello che ci pare, addomesticandone natura e origine secondo regole che con gli oggetti (le esperienze) niente hanno a che fare.
Cioè, per esempio, accade che quelle ricorrenze manifeste che sembravano sollecitare appunto una descrizione, una possibile classificazione, sfuggano all’esame. Non si vede il perché e come, al di là di economie e esigenze legate all’apparire (incredibile pensiero dato per scontato il low budget del teatro-raccontare), se questa disposizione prende piede esprime forse un punto critico di relazione proprio tra lo scrivere (inteso in senso lato come anche esserci, intervenire nel reale) e il leggere (anch’esso inteso in modo ampio come esperienza del reale e dispiegamento delle nostre facoltà percettive).
Non si vede come, più in profondità, proprio attraverso un fenomeno così contradditorio il teatro racconti (e sia testimone, come in ogni epoca, d’altronde) delle istanze e delle urgenze più radicate nell’epoca in cui si esprime. E’ la discrepanza quasi irrimediabile tra l’esperienza del reale e la sua elaborazione, è la frattura, la ferita sanguinante inferta alla lingua e alle sue (possibilità ) dinamiche di modificazione; sono questi i grumi sofferenti in cui si istituisce un’esigenza-urgenza non più procrastinabile di ricomposizione della polarità fondante fra identità e linguaggio. Proprio perché questa è la polarità aggredita dall’imperio dell’economico, della misurazione della realtà in termini di Mercato.
E il teatro – che peraltro è sintesi stupefacente, nella sua natura, fin dalle origini, e in modo incontrovertibile, dell’integralità tra lingua, quindi anche racconto, storia, e sensi – è lì a dirci, nella sua fenomenologia, nel suo spendido e volte becero disordine, che lui c’è. Qualsiasi tentativo di farne cenerentola fallisce davanti all’intrinseca capacità di trasformare e spalancare il proprio spazio di elaborazione nelle forme che, dialogando con le epoche, reinventa e scrive.
D’altra parte non v’è altro modo in cui il reale possa finalmente farsi leggere – quanto meno quello è lo strumento con cui forse ci si può provare – se non, come si diceva, con quel raccontare; come se ci fosse qui invenzione; come se, anche se fosse, non sarebbe per necessità supplente alla sempre più assillante strategia di espropriazione che il teatro, in qualche caso, si è rimesso a raccontare.
Quel che appare utile, qui, dunque, a non precipitare in babeliche battaglie (per lo più finte, come tutte le guerre, le cui giustificazioni apparenti, nascondono conflitti di potere) è demistificare, “fare a botte”; non distruggere o classificare, ma sospingere nel baratro, nel suo inferno matematico chi pretende di decidere che cosa e come, quale sia o debba essere il canone; serve non canonizzare, serve vivere, mangiare, bere (e un po’ di altre cosette), ricordandosi che, anche se fosse:
[giampaolo spinato]