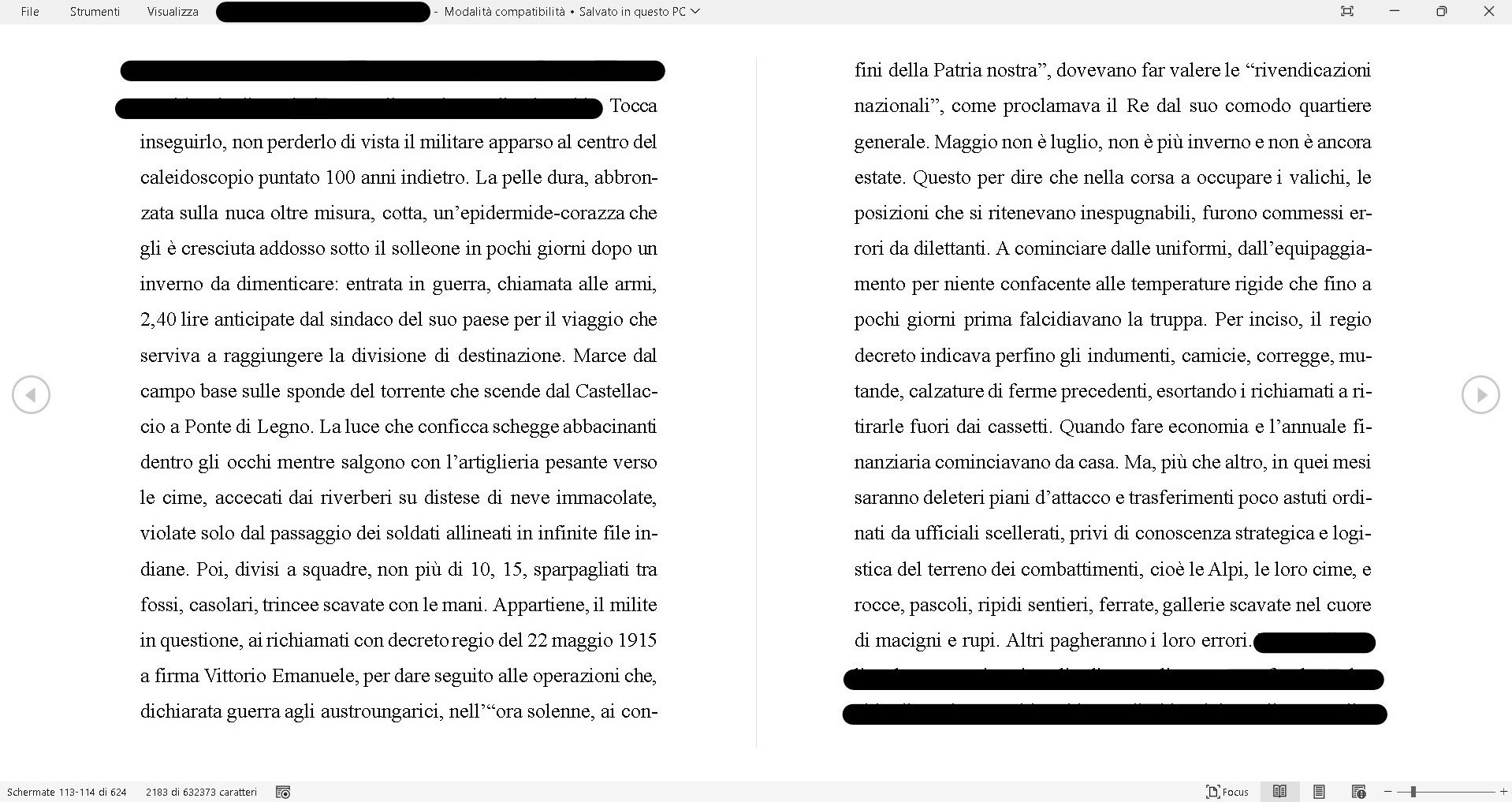I primi 5 minuti dopo una morte violenta sono passati da un pezzo, e non c’è limite al peggio (a meno che)
Appunti per un intervento alla tavola rotonda intitolata L’autore non abita più qui? – Il rapporto tra autore drammatico e regista nel sistema teatrale italiano, venerdì 30 novembre 2012, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali
Prendo a prestito il titolo di questi appunti da un pezzo musicale di un gruppo di musica elettronica sperimentale[1], per esprimere in sintesi il mio pensiero sul tema di questa tavola rotonda.
L’autore non abita più qui?, non dovrebbe essere una domanda ma una consapevolezza acquisita. La risposta dell’Angelo alla pia visita di uomini e donne al suo sepolcro. Mi avvalgo di questa allegoria post-pasquale perché affermare – e non domandare – l’autore non abita più qui stabilisce il punto profetico di non ritorno della trasformazione che il lutto, ogni lutto, se non aggirato, consente. E ci equipaggia degli strumenti indispensabili per celebrare la laica resurrezione a cui più o meno tutti aspiriamo. Intendo chi abbia a che fare con il daimon della parola e della scrittura nei suoi diversi coniugamenti.
Ma, prima la morte. L’omicidio è stato consumato. Abbiamo una scena del crimine. È quella a cui allude la domanda. Dov’è finito l’autore equivale a domandarsi dov’è la parola. Dov’è la sua fonte. Chi la decide. Da dove è sgorgata. Io preferirei dire: chi ne è stato attraversato o se n’è lasciato attraversare. E all’improvviso ci accorgiamo che di questa identità – abitata, assediata, posseduta dal daimon-parola – non vi è più traccia nella qualificazione efficientistica dei ruoli e delle funzioni stabilita dalla scienza della divisione del lavoro. All’improvviso, appare chiaro che all’“autore” è capitata la stessa sorte del maestro di bottega prima medievale e poi rinascimentale, espropriato del proprio sapere, suddiviso in tanti microscopici specialismi che hanno spostato la conoscenza complessiva della produzione dell’opera – e quindi il potere di disporne e deciderne la lavorazione ma anche la sorte – in un altrove che oggi è ben rappresentato dalla polarità stridente che esacerba l’economia e le società nella tensione tra capitalismo finanziario e impresa “concreta”.
Abbiamo il cadavere dell’autore, la cui identificazione, nel disorientamento creato dalla stratificazione e dalla distorsione dei significati che via via sono stati attribuiti a questo termine, ci sfugge. La consunzione di questo corpo, la sua mummificazione, nella migliore delle ipotesi – cioè quando non sia stato sciolto nell’acido – ci consente al massimo di farne l’autopsia. Ma i rimasugli che gli troveremo nello stomaco, non ci diranno granché. È passato troppo tempo. Il tempo celebrato della mistica della comunicazione che altro non ha fatto negli ultimi decenni se non incidere nel già delicato equilibrio-confronto comunicativo connaturato con il linguaggio (che prevede un continuum narrativo tra le persone che vengono a contatto, prevede scambi di storie ed emozioni, altro che vettori e algoritmi come ha preteso di insegnarci l’ideologia semiotica prima e il totem binario della tecnologia poi) accelerando la separazione e la distanza tra chi, nella lingua, si dovrebbe incontrare.
Questo assassinio ha un movente: disciplinare l’elaborazione e la diffusione di senso, annientando la figura (l’Autore cos’è se non il Me di ciascuno incaricato di restituirci una visione del mondo?) ma anche la fatica che questa facoltà comporta. Questa regolamentazione del confronto con i significati, consente una veicolazione più orientabile di contenuti. Consente il controllo. Nello specifico, la preponderanza direi tecnicistica di una figura come quella del regista, che ha avuto la sua apoteosi nel Novecento, collude con questo disciplinamento, relegando la quota di autorialità che compone insieme alle altre competenze tecniche la sua figura in una frigida esercitazione estetica, al massimo uno sfolgorio ipnotico, suggestivo e museale di esibizioni erudite. Con un colorato corredo di narcisistici virtuosismi dell’intelligenza che appagano i sensi per il tempo che serve alla digestione dell’esperienza estetica.
Lo scopo della marginalizzazione dell’autore, e forse anche della nebulosità semantica in cui lo si è soffocato (il termine), è quello di silenziare definitivamente la meraviglia – intesa come sbalordimento e nel contempo terrore – che solo il corpo a corpo autentico con la parola può innescare. Non è cosa da poco riuscire a sostituire uomini e donne con utenti e consumatori. Occorre scienza, altro che fantascienza.
L’arma del delitto. Ovvero la modalità, premeditata, sofisticatissima e ormai collaudata, non si identifica con l’armamentario prosaico e cruento a cui eravamo abituati. Non serve – non nei Paesi civilizzati e ad alto tasso di democrazia – la soppressione fisica. Benché in qualche caso rimangano dei dubbi, se appaiono veri, ad esempio, alcuni sospetti che si sono riaffacciati sulla morte di Pasolini… No, l’arma per la deautorizzazione è la stessa che espropria l’individuo dello spazio intimo di confronto simbolico schiacciandolo in una realtà contabile di rapporti di forza in cui i valori, tutti i valori, sono traducibili in moneta. In questo contesto, la sagacia di uno Shakespeare non potrebbe che vendersi-dedicarsi al copywriting, altro che bisbetiche e riccardi. Come qualche talentuoso suo erede che lavora in pubblicità è riuscito a fare con Beckett e Godot, venderebbe divani con Falstaff.
Un accelerato trasferimento di sapere a spese della scrittura, delle dinamiche tipiche e archetipiche della produzione letteraria e del corpo a corpo con la parola ha peraltro dato una certa baldanza a molti settori dell’economia e della comunicazione. Ricordiamo quando certi giornalisti dicono “adesso vi raccontiamo la storia”. C’è chi lo fa con la coscienza sporca di sapere che la cronaca non può affatto raccontare una storia, essendo il racconto di una storia tutt’altra cosa rispetto alla sua illustrazione. La riduzione delle potenti deflagrazioni di significato che abitano una storia a legnoso aneddoto ha uno scopo preciso: quello di riempire la mangiatoia dello scaffale pubblicitario secondo le esigenze dello sponsor.
Questo massacro continuato si è consumato e ancor oggi si consuma nella mistica della comunicazione. Molti altri esempi si potrebbero portare. Dall’illusione che ha permesso il democratico – apparentemente – accesso alla pubblicazione, facendo saltare i meccanismi elitari e di classe che ci hanno preceduto, in realtà buttando via l’acqua sporca con il bambino. Trovatemi non un editor con la cultura o l’erudizione di Calvino o Vittorini. Ci sono. Ma con il potere (e a volte la risolutezza, le palle) dei Calvino o di Vittorini, il cui vantaggio, forse, era di non avere – ancora – la pistola del marketing puntata alla tempia, o forse sapevano farlo stare al suo posto. Entrambe le ipotesi sono senz’altro meglio del far finta di niente, compiacendosi di recitare un ruolo autorevole che non si ha più, cercando di non farlo sapere troppo in giro, come capita di fare a qualche loro erede.
E, insomma, Angelo, dove sta l’Autore? Dov’è la sua laica resurrezione? Vi sono almeno due scenari da considerare. Il primo: separarsi dalla cultualità novecentesca dell’Autore. Dal patetico, vertiginoso spasmo narcisista che, vellicato dall’illusione di deità insito nell’elaborazione-ricreazione di un mondo, ha indotto parecchi a scambiare il proprio magistero con un piatto di lenticchie. Penso alla pletora di critici passati (che vorrebbero passare) dall’altra parte della barricata, peraltro senza volere neanche pagare il prezzo che paga chi, spesso lui nolente, in quel (al) di là ci è nato, è rimasto inchiodato come a un perenne arresto domiciliare da cui non c’è modo di evadere.
Dunque, recupero delle identità.
Secondo: disciplina. Altro tipo di disciplina da quella che regola controllo, censura ed autocensura. Un separarsi dalla cultualità narcisistica dell’Autore che ha per conseguenza il recupero dell’intima conoscenza delle dinamiche e delle responsabilità che implica il suo lavoro. Questa consapevolezza introduce una prospettiva che consente una migliore comprensione delle strategie con cui si induce chi scrive ad adeguarsi al conformismo, e permette di riprendere coscienza del primato naturale della parola, imparando a introdursi con più ingegno e disinvoltura fra gli interstizi che la divisione del lavoro, la sua specializzazione e il suo disciplinamento hanno creato. Scrivere oggi – anche scrivere per il teatro – è un esercizio marziale dell’arte e richiede la lungimirante, risoluta modestia di monaci guerrieri. Che non pietiscono spazi. Non piangono sulle proprie frustrazioni. Non si lamentano della noncuranza con cui si cerca di silenziarli. Ma inventano nuovi modi per veicolare ciò a cui per vocazione sono chiamati, dimostrando che senza di loro – i significati che ne attraversano i corpi e le menti – tutto ciò che sta intorno cadrebbe come un castello di carte. Non è, non può essere una battaglia sindacale, perché il primato della lingua è nella storia e nei fatti. Dunque è, e basta. Persino, malgrado gli autori o chi ambisce a essere riconosciuto come tale. Fuori dalla parola e dalle sue trasformazioni – compresi i fraintendimenti e gli inganni grandiosi che consente – non riusciamo nemmeno a concepirci. E non ci sarebbero un bel po’ di altre cose. Se è vero, com’è vero, che non Freud ha inventato la psicanalisi, ma il mito. Ovvero la letteratura. È dalla scrittura che da vengono la scienza, la religione, la vita su Marte e, Higgs lo sa, persino il suo promettente Bosone. Se uno è cosciente che le cose stanno così, non teme nemmeno di rinunciare persino al proprio nome sul frontespizio di un libro o sulla locandina di uno spettacolo. Che sarà mai? Se tutto ciò non sarebbe esistito senza i significati passati attraverso di lui.
30/11/2012 – 2/12/2012
[1] I Coil, molto di nicchia ma saccheggiatissimi tra il 1984 e il 2004, cioè nei vent’anni della loro parabola artistica, fino alla morte di uno dei suoi fondatori, John Balance. Il pezzo a cui si fa riferimento è The First Five Minutes After Violent Death, uscito per la prima volta nel 1987 in Gold Is the Metal with the Broadest Shoulders. Per gli specialisti va distinto da The First Five Minutes After Death, inserito l’anno precedente in Horse Rotorvator con un errore di titolazione.