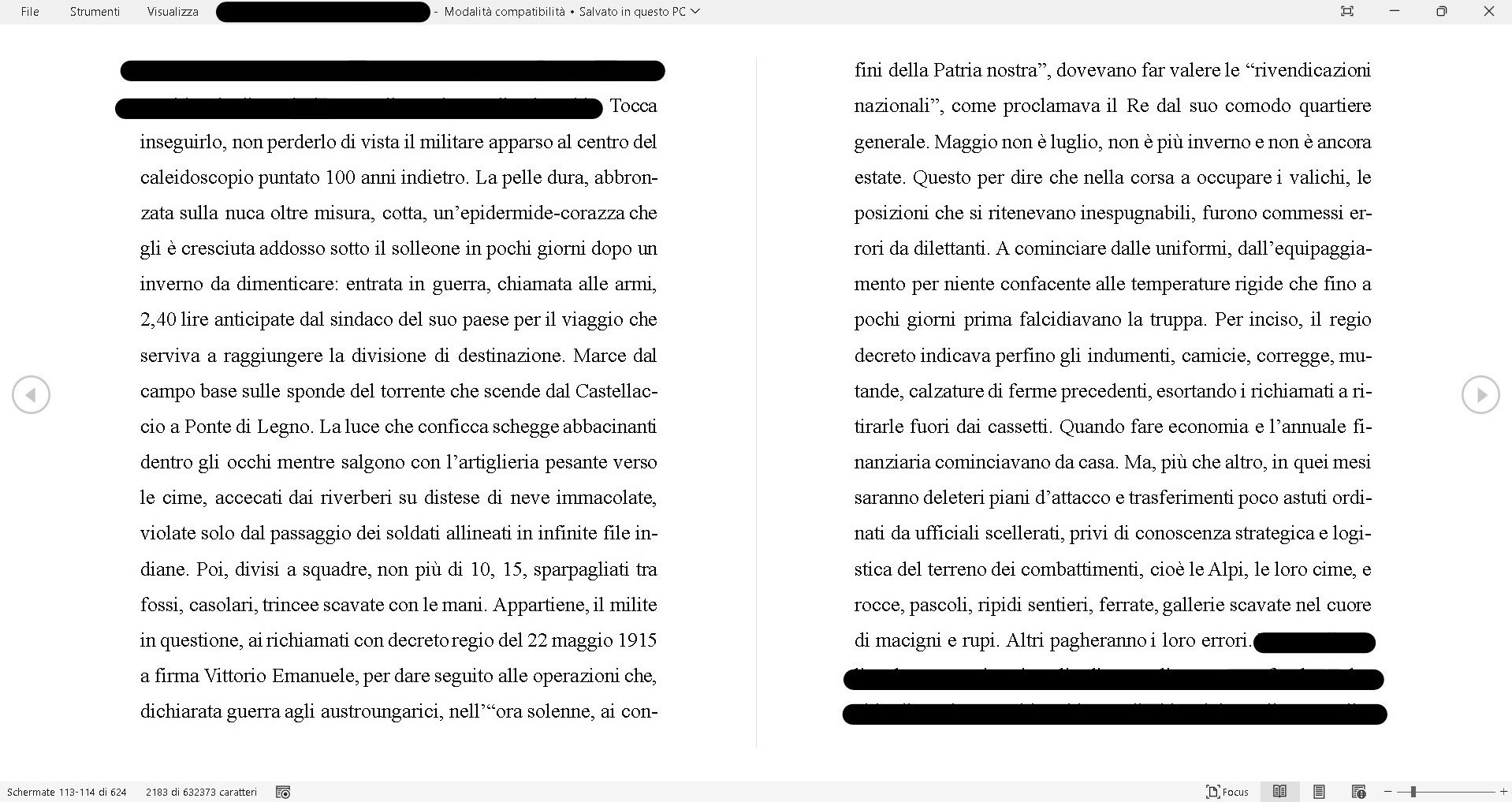Uno degli istituti che strutturano intimamente i canti funerari è quello della citazione.
Se escludiamo dall’analisi, per l’ovvia, intrinseca stortura positivistica impressa dalla boria enciclopedico-scolastica alla produzione letteraria di origine e scopo accademici (tesi, tesine, etc.), il prontuario citazionistico imposto a intere generazioni di studenti (con tanto di modellistica e indicizzazione ormai digitalizzata, si pensi ai brevetti per applicativi e software dedicati all’analisi di rimandi ed occorrenze che stanno gonfiando conti correnti di magnati dell’informatica ma anche di idioti con indubbia capacità manageriale), rimangono da visitare vaste aree comportamentali che comunque hanno a che fare con l’istituto della citazione.
Una di queste, forse la più allettante dal punto di vista degli spazi di smascheramento che può offrire, riguarda l’abitudine a ricorrere alle parole e opere altrui, meglio se sufficientemente noti e celebrati (questi altri utilizzati), per mettere le mani avanti e convalidare a priori le proprie convinzioni senza tema di smentita.
Che si eserciti nella conversazione o nella comunicazione scritta (relazioni, discorsi, etc.) è del tutto indifferente. Ciò che conta, qui, una volta compresa la misura e valutati gli intendimenti persuasivi, gli scopi di questo ravanare fra le “perle” altrui, è discernere la reale pertinenza col proprio discorso dei contenuti di cui ci si appropria.
Tale analisi non appare così difficile. Si pensi all’opportunismo plateale (e talvolta funzionale) di certi discorsi parlamentari e alla piega polverosa ma chissà perché ancora oggi reputata così nobiltante assunta da simili interventi secondo il grado e la rarità delle citazioni con cui sono infarciti.
Lo stesso dicasi per i discorsi che, anche nella quotidianità, con gli stessi principi, aspirano sostanzialmente ad autolegittimarsi con l’operazione (unilaterale) di apporre firme autorevoli alla propria asserzione. Ciò può avvenire, come è facile immaginare, nell’oscurità di un’alcova o al banco di un bar. Si tratta, in pratica, di una vera e propria petizione, di una singolare e autarchica “raccolta di firme”, studiata o improvvisata a scopo persuasivo, seduttivo, affermativo.
Oltre una certa quota (di ironia, anche, di gioco, di intrattenimento ludico e di danza seduttiva, appunto, con tutti gli aspetti divertenti o noiosi del caso, che dipendono ovviamente dalla disponibilità, dalla maturità e dalle intenzioni degli individui coinvolti, per i quali, come si sa, non sempre il contenuto comunicativo corrisponde alle parole dette, all’apparato e alla coreografia linguistica allestita) il ricorso all’istituto della citazione sollecita il sospetto che chi vi ricorre, in realtà, non creda poi così tanto a ciò che sta affermando e vada dunque smaniosamente in cerca di compagnia autorevole per accompagnare (e sostenere) il proprio parere o sentimento.
Senza inoltrarci in una casistica che, convocando fragilità o patologie riconducibili all’identità, assumerebbe proporzioni troppo vaste e peculiarità non sufficientemente prevedibili per gli strumenti assolustistici della statistica e dell’enciclopedismo accademico, potrebbe però risultare davvero interessante rilevare (e demistificare) uno fra i più diffusi di quei comportamenti e l’aureola postmodernista che, per opportunismo reciproco, chi ne fa uso e chi ne fruisce, spesso, gli attribuisce.
Stiamo parlando di una variante molto elastica e curiosa dell’istituto della citazione. Quella che imprime aura di up-to-date, “avanguardia” al discorso monco, infarcito di asserzioni che, appoggiandosi strumentalmente ai principi di contaminazione e meticciato, perpetra il saccheggio contenutistico di, in fondo, non ha niente da dire, anche se lo dice su un giornale o in televisione (a volte, proprio per questo).
Una spia divertente di tale vuoto identitario, della voragine di assenza che scava in profondità, dietro la maschera, chi si destreggia con disinvoltura e con l’istituto della citazione (ostentandolo) e con la malia teoretica della contaminazione (per allestire ruffiani sfondi intellettuali all’impersonalità delle proprie asserzioni), è la spasmodica cura della propria immagine, non solo per mezzo di artifici retorici, ma attraverso sofisticate e snobistiche venature understatement, quando non preferisca ancorare il totem del proprio sè sullo sfondo suggestivo e evergreen dell’off, dell’out, del contro o dell’underground, aree di rara efficacia sotto il profilo dell’inseguimento delle mode.
In questo gioco perverso e, a dire la verità, se si escludono evidentemente gli effimeri lassi temporali di “ritorno d’immagine” (prospettiva che, in ogni caso, innestandosi non nell’area esperienziale e imprevedibile delle relazioni, ma nel mercato esclusivo dei rapporti di forza, richiede un investimento a lungo termine per garantire la visibilità e l'”autorevolezza” disponibili sugli scaffali di quel mercato), si struttura, scorrendo dapprima per carsici, sotterranei meandri, poi, una volta riempito il centro dell’identità del proprio pietrisco, e infine levigandone la lucida, impenetrabile patina di superficie, si struttura, dicevamo, un’assenza di identità che prodromo della disperazione, portata a passeggio con irriducibile spocchia o “ridendo”, ovvero, subendo il lancinante affronto di quella paresi muscolare facciale a cui ci ha assueffatto, per esempio, la televisione o la fotografia promozionale: una malattia del tutto trascurata e, per ora, a quanto pare di capire, irreversibile, a meno di un intervento “duro” della realtà e dell’esperienza, in grado di abbattere la solida scorza rappresentativa, la tomba a cui, per inclinazione o per scelta, è stata consegnata la fragile identità in questione.
Che tale modalità tenti di nascondere, senza davvero riuscirvi, una preclara povertà di senso, è sotto gli occhi di tutti. Così come è visibile la pirotecnia autistica e schizoide che vena la produzione espressiva del campione della citazione, facendo della sua bocca (ma anche di ogni altra parte del corpo e di ogni supporto espressivo a cui ricorra) una curiosa centrifuga del nonsense, della ginnastica semantica fine a se stessa (ma, certo, qualche scopata, qualche articolatto sul giornale ci scappa), una splendida e celibe variazione biologica dei robot domestici e delle mirabilie che sono in grado di fare con cibi, carni e verdure.
Da un certo punto di vista, la varietà e la sorprendente capacità produttiva di questi soggetti, esercitano un fascino a cui è quasi impossibile resistere. E dunque, la sola osservazione di tali fenomeni apre porte conoscitive di non poco interesse sotto il profilo antropologico e nell’indagine dell’animo umano. Ma, al di là, del godimento garantito da questo “spettacolo” e delle sue più scoppiettanti declinazioni, una costante incandescenza, di inimmaginabili potenzialità ustionanti, dovrebbe permanentemente allertarci nella fruizione di tali performance, inducendoci quanto meno ad amministrare con oculatezza tempi, modi e dosaggi con cui le approcciamo: poiché all’origine di tale inclinazione c’è una cultualità mortale, in questo caso del sè, in debito permanente di riconoscimento (da parte degli altri, ma soprattutto proprio da parte di se stesso), ed è da tale penuria, da tale sconfinata sofferenza che si struttura un destino egotico di spasmi autoreferenziali, di coma profondo dell’io avvolto nel virtuosismo mirabolante e, a volte, anche fantastico di un meticciato discorsivo (preferibile peraltro alla fatica di denunciare le fonti del proprio discorso), di una contaminazione così ideologizzata (tutti sanno che la contaminazione accade nella relazione e nell’esperienza espressiva senza alcuna necessità di approntarne una modulistica preconfezionata) da svelare, dietro la classica e impasticcata euforia sopra le righe con cui si rappresenta, il volto indicibile della paura davanti alla morte, al vuoto, al nulla, tutto ciò a cui si è rinunciato a dare forma e personale significato o struttura.