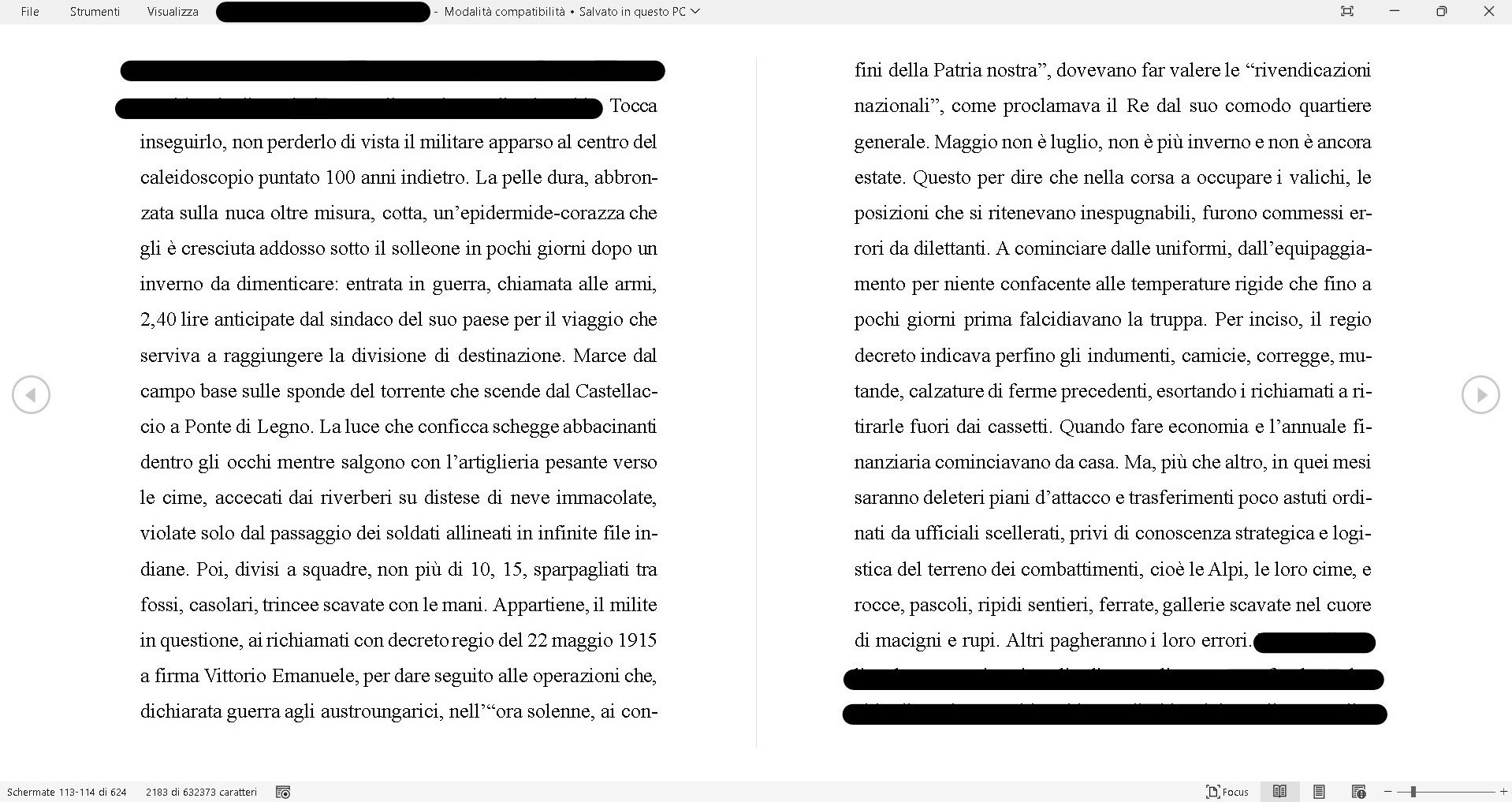Liberi dalle squame pelose e pigre dei coccodrilli, degli eruditi pianti, sempre postumi, che subito, presto, a cadaveri ancor caldi, o a distanza di decenni, perduranti, nei casi celebranti o celebrabili per le ragioni più diverse ancorché spesso cerebrolabili (nel senso della labilità, della povertà di sensi aggiunti da cervelli abituati a cannibalizzare altri – purché morti – per autolegittimarsi); fuori da contesti così stereotipati, lontani dai miasmi aciduli (o dolciastri) distillati dentro libri, saggi, articoli, convegni, in durevolissimi ma prezzolati funerali, rimangono le cose, gli uomini, e i lasciti testimoniali delle rappresentazioni (opere genericamente dette, qualsiasi sia il genere in cui si voglia stringerle) con cui, in vita, hanno curato febbri e cicatrici di euforie, di rabbie, di dolori.
Ed è a queste secrezioni, al loro organico disporsi in significati, shock, lamenti, attraversamenti, che ci si dovrà rifare, sempre, senza sconti, specialmente in casi assai acclamati, al di là delle classifiche, dei cataloghi, di pesi e di misure stabilite dai presunti eredi o depositari di diritti (siano essi figure parentali o procuratori, agenti ed editori), per commisurare, scegliere, verificare le verità raggiunte da quel corpo di percorsi e rappresentazioni.
Cosa che non piace, affaticante, meno prevedibile e rassicurante di un canto funerario in corpo 11 da vendersi al miglior offerente. Difficile il confronto, sicuramente meno remunerativo (nell’apparenza di spettanza, di moneta), dell’istituire e cavalcare tigri, compromettenti ma strumentali culti, certi, con richiami e virtuosismi di rimandi, di raggiungere ben altri intenti di quelli in superficie dichiarati.
A chi servono, a chi serviranno, infatti, i culti?
Quale vantaggio, quale nutrimento offre ai potenziali suoi fedeli, l’idolatria della reliquia?
Di quali, fredde o calde, stimolazioni potrà far tesoro il postumo (rispetto al celebrato e, spesso, al celebrante stesso), irretito nel tortuoso itinerario che, adorando, idealizzando, sclerotizza, uccide in senso proprio, la vita implicita, contraddittoria, vivida e per nulla riducibile di un’opera che nemmeno la dedizione più autorevole (figuriamoci se sottilmente strumentale o arrogante, anche) potrà mai davvero circoscrivere al supporto (libro, quadro, nastro, disco, etc.) che materialmente la contiene?
E se la qualità intrinseca del canto funerario con annotazioni, prolusioni e postfazioni, fosse inevitabilmente quella di disinnescare – con stratificazioni e orpelli del tutto avulsi dalle combinazioni di alfabeti, i corpi-insiemi di significati (dunque, le esperienze) non surrogabili a cui sono applicati?
Se avvicinarsi e penetrare, senza altri intendimenti che non siano la determinazione a farne l’esperienza per conoscerli; se l’accostamento a questi oggetti-corpi, ai lasciti di autori, artisti, avvenisse più compiutamente nella sospensione della riverenza, nell’assenza di secondi fini (rientrassero anche nell’ingenua o inconsapevole ricerca di conferme a ciò che già sappiamo), nella compenetrazione intima, nel corpo a corpo, la battaglia che polarizzando idee, figure, sensi, può spalancare incognite, generare intendimenti, opere, ricerche e percorsi inediti?
Se i maestri, i capolavori cosiddetti ci chiedessero, ma sarebbe meglio forse dire implorassero di essere raggiunti senza doppi sensi e poi smentiti, irriverentemente sottoposti a amplessi paritetici, violati, per poter continuare a essere vivi, per essere davvero compiutamente riscattati dalle lapidi, dai loculi, dagli epitaffi in lettere dorate che una violenta e compaciuta forma di rispetto (ovvero esattamente il suo contrario) si ostina a cesellare per straziarli, finirli, profanarli nella suggestiva, rassicurante liturgia di tutti i culti?