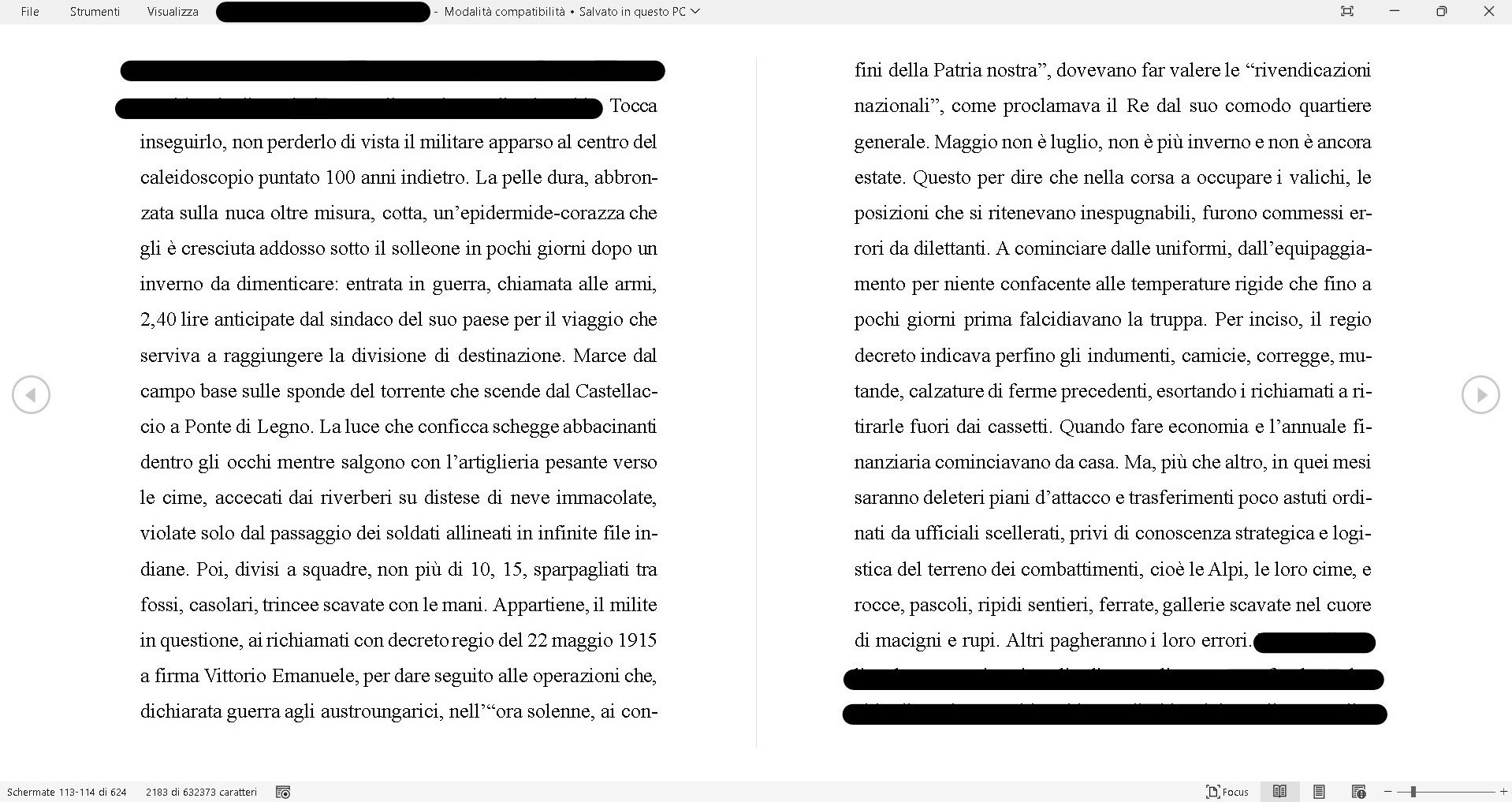(pubblicato su Hystrio, anno XVI, n. 2, aprile-giugno 2003)
:::
Non conosco gesto che non sia “politico”, che non convochi cioè nel solo suo dispiegarsi una visione del mondo e dunque una relazione con la realtà. Trovo perciò fuorviante parlare di “teatro politico”. Una forma forse un po’ estrema (necessaria?) di precisione e rispetto per le rappresentazioni e l’opera d’arte nell’epoca della sua autopsia estetica, mi spinge a sfilarmi dalla confusa cornice di discussione creata da questa etichetta quando si riflette, anche sulla scorta di un fenomeno diffuso, sulla relazione fra teatro e politica.
Esiste, appunto, un fenomeno. Molte rappresentazioni cioè si occupano, anche esplicitamente, in questi anni, di politica. Ma l’assunzione di un “canone” come definizione stentorea, come marchio, credo che nasconda le contraddizioni e le dinamiche che animano questo fenomeno, invece di mostrarle.
Esempi illuminanti di relazione fra il teatro e il “civile” o il “politico” (dal primo Novecento russo all’esperienza del Teatro di Base, per tracciare una polarità puramente cronologica) ci hanno portato in dote quella consapevolezza che, per fare solo due rimandi, è espressa in modo superbo da Heiner Müller1 o nell’analisi di Kafka ad opera di Kundera2 quando afferma la paradossale vocazione storica, e quindi, aggiungerei, anche “politica”, di un’opera solo apparentemente “disimpegnata”.
A queste e ad altre autorevoli voci si può, forse si deve ancorare un confronto sul tema. Magari per affermare, senza fraintendimenti, non solo che, di per sè, un “teatro politico” non esiste, ma che sarebbe auspicabile che non esistesse. Perché ogni rappresentazione, compresi quindi i “teatri possibili”, se connotata a priori, anche solo per comodità espositiva, rischia di snaturarsi, snaturare l’irriducibilità del gesto creativo, rimanendo invinghiata in ricatti interpretativi che, caso per caso, per opportunismo o smania di classificazione, per intenzioni ad essa estranee o usi strumentali dei suoi contenuti, deviano l’attenzione dal luogo in cui si realizza “quel” gesto: il suo “accadere”, la densità di sensi innescata nel confronto con chi ne partecipa.
E’ in questo evento, in questo “contatto”, che si modulano, alla fine, scoperte, intuizioni, pregiudizi, crescita o stagnazione sia della rappresentazione che dei suoi “partecipanti”.
Per quanto difficile da nominare e osservare, è proprio a partire da qui che si può provare a “vedere” come storia e discorso3, forma e contenuti si coniugano, quali strade spalancano e quali sbarrano. Non mi sembra vi siano altri luoghi in cui la verifica e lo scambio di significati, con tutte le loro dinamiche, si possano realizzare più autenticamente prima di diventare “dominio” di secondo o terzo grado, pura meta-para-testualità . Questo vale anche per le istanze politiche nelle/delle rappresentazioni. Se si vuole cogliere, al di là di punti di vista, ideologie o schieramenti precostuiti e legittimi, l’autenticità, la verità, la forza, in una parola l’Alterità interrogativa e nutriente di un’opera d’arte, bisogna parteciparvi, farne esperienza. Per esempio: basta fare un film o uno spettacolo contro, poniamo, l’Olocausto, per “Essere” (lei, l’opera, e chi la concepisce) contro l’aberrazione? E’ sufficiente (e la renderà più efficace?) chiamare “civile” una rappresentazione perché sia davvero tale? Non lo credo. Come non credo che etichette, spiegazioni, interpretazioni possano sostituirsi al “qui ed ora” della rappresentazione che, com’è nella natura del teatro, non può dirsi tale finché non “accade”, e fino ad allora non è che supporto (libro, pellicola, nastro, tela, spazio-materia scenotecnografata), promessa di un qualcosa a venire.
Di qui la disposizione molto personale a leggere e valutare efficacia, asperità, lucidità o pressapochismo anche di una tensione “politica” interna alla rappresentazione solo nel suo manifestarsi (mettendo in discussione in questo confronto anche i propri limiti, nella misura del possibile). Di qui il sospetto per il “genere”, la canonizzazione di un fenomeno che – ed eccoci tornati alla “politica” nel teatro – in quanto tale, può avere ed ha radici nella realtà4 ma che da questa, per “illudersi di” o “provare a” comprenderla (e qualche volta a tollerarla più che trasformarla), nel momento in cui si fa rappresentazione, non può che distanziarsi per ri-crearla. Di qui però anche la disponibilità a osservare un fenomeno, in quanto tale, nella sua integralità . Nel suo incresparsi di necessità e urgenza che non ne assicurano a priori l’efficacia, ma raccontano proprio il bisogno di tematizzare certi contenuti e non altri. Nel suo contraddittorio manifestarsi e contaminarsi, chiamando in causa altri canoni (l’uso di un altro, equivoco, “genere”, il “teatro di narrazione”, per esempio, è un fenomeno che racconta il fenomeno, cioè a che punto sia l’elaborazione dei linguaggi, la loro invenzione e talvolta la rinuncia alla loro rigenerazione; ma spesso racconta anche semplicemente il bisogno di trovarsi un “mercato”).
In questa trasversale e stratificata fenomenologia si apprezzano però, prima delle consapevolezze o delle intuizioni che pulsano in una rappresentazione matura (non per forza compiuta), i rigurgiti di una vitalità paradossale e stupefacente che identifica il teatro per la sua sana irriducibilità . La capacità di radicarsi nella realtà e di esserne un sofisticatissimo, attento sensore. Che nel suo manifestarsi si aggreghi o disgreghi dinamicamente, succhiando o supplendo ad altri specifici (letteratura, videoarte, pittura e quant’altro) può e deve essere terreno di pratica e analisi. Quanta supplenza all’analfabetismo emotivo derivato dal non leggere (cioè dal non sapere più “respirare” uno spazio simbolico individuale di ri-creazione del mondo) c’è ad esempio nell’abuso della narratività a teatro? Quanta, fertile o manieristica, crisi di istituti dati per scontati (“personaggio”, “conflitti” e strutture drammaturgiche così come tramandate dalla tradizione) fibrilla in questo “movimento”? Quanta urgenza, autenticità, sbrigatività, “moda” si imprimono di volta in volta, anche attraverso il corpo, la biografia del singolo artista, in una rappresentazione riconducibile a canone? O ancora: in che misura, e come, la controinformazione, rompendo il monopolio mediatico, quindi scaturendo da un bisogno anche oggettivo, può dispiegarsi efficacemente in uno spettacolo smarcandolo dal piatto agit-prop?
Come si vede, non manca lo spazio per un serio confronto che, dissodando il terreno, preceda o prepari il teatro a venire. In fondo, l’accento sociale e politico che attraversa oggi il teatro racconta forse anche in parte ai mistici del Mercato Globale che i Significati e le loro Rappresentazioni, per quanto invisibili e non misurabili, sono reali, concreti. Alla fine, il suo essere non addomesticabile, la natura speciale che, come messa a fuoco di relazioni, eleva il teatro, al di là di generi e canoni, a sorgente fondamentale di ogni rappresentazione, garantisce la sostanza e la potenzialità non esauribile di questa esperienza: il teatro è il senso profondo dell’arte. E la “politica”, l’etica, la religiosità, le visioni del mondo che convoca, si trovano, volta per volta, disintegrati o riformulati, nei significati che disinnesca o che innesca. Che è come dire: nella sua “poesia”. Non c’è sondaggio, statistica, formula o codice a barre che tenga.
1 Heiner Müller, “Tutti gli errori”, Ubulibri, Milano, 1994.
2 Milan Kundera, “L’arte del romanzo”, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano, 1988, (in particolare il capitolo V, “In qualche posto là dietro”, pp. 143-167).
3 Nell’accezione formulata da Seymour Chatman in “Storia e discorso”, Parma, Pratiche Editrice, 1981.
4 Come non rilevare, dalla caduta del Muro di Berlino alle Twin Towers, ma anche scorrendo la cronaca politica e giudiziaria italiana degli ultimi anni, che di per sè i tempi “convochino” tutti, anche i più sordi o distratti, attorno ai temi sociali più urgenti?